Il “velo” della traduzione

- «… andare a toccare “quello” che si chiama “velo” si-
- gnifica andare a toccare tutto. Non lascerai niente di in-
- tatto, sano e salvo, né nella tua cultura, né nella tua
- memoria, né nella tua lingua, dall’istante in cui comin-
- cerai a prendertela con la parola “velo” (voile). Dall’i-
- stante in cui ti lascerai prendere in lei, nella parola, …
- niente resterà, più niente resisterà».
- Jacques Derrida, «Un baco da seta.
- Punti di vista trapunti sull’altro velo»
Come non pensare alla rilevanza del “velo” come oggetto centrale alle più varie discussioni civili, razziali, culturali della contemporaneità? La rilevanza dell’oggetto-parola, il velo, è al centro del desiderio diasporico delle giovani musulmane coinvolte nel recente ed inedito dibattito francese sull’integralismo e l’integrazione; il velo, l’oggetto-parola, è stato al centro di un nucleo di scritture e di riscritture fondamentali alla questione dell’identità nazionale e femminile – è il tessuto intrecciato dalle riflessioni di FRANTZ FANON, «L’Algeria si toglie il velo», Opere scelte, Pirelli, Torino 1971; di ASSIA DJEBAR, «Sguardo vietato, suono tronco», Donne d’Algeri nei loro appartamenti, Giunti, Firenze (1980), 1988; e di FATEMA MERNISSI, «Lo Hijab, il velo», Donne del Profeta. La condizione femminile nell’Islam, Ecig, Genova 1997. Recentemente, due importanti pubblicazioni sono state dedicate al “velo”: «Voile», Contretemps, 2-3 hiver-été 1997 (qui, in particolare, vedi FETHI BENSLAMA, «Le voile de l’Islam», che reinterpreta l’intero dibattito alla luce del “segno” e della “dé-monstration”); e DAVID A. BAILEY – GILANE TAWADROS (a cura di), Veil, Veiling, Representation and Contemporary Art, Institute of International Visual Arts, in associazione con Modern Art Oxford, London 2003.

…….
La pura lingua (Walter Benjamin)
- «… le sue passioni non sono fatte d’altro che della parte
- più fine del puro amore»
- William Shakespeare, Antonio e Cleopatra
Walter Benjamin è il filosofo che, nella modernità, ha tenuto più a cuore lo spirito della riflessione utopica. Il testo che declina tale radicalità in relazione alla lingua è «Il compito del traduttore», la prefazione alla traduzione dei Tableaux parisiens di Charles Baudelaire, dove il filosofo mette a fuoco la problematica della lingua in rapporto a ciò che avviene tra il testo originale e la traduzione, con un’enfasi sulle questioni della comunicazione e della storia(1).
In questo saggio, per Benjamin, la lingua dell’originale non si dispiega in essenzialità nella comunicazione, nella ricezione o nella rappresentazione, ma nell’«inafferrabile, misterioso, “poetico”» che le permette di essere percepita ed amata. La traduzione che voglia trovare la propria essenzialità nei confronti del testo originale, si scrolla anch’essa, forse ancor più, dei principi di rappresentazione e di comunicabilità, per darsi come “forma”. È una forma che ha un rapporto necessario e storicamente definibile con l’originale: l’opera che ha esperito la maturazione storica, che ha raggiunto il momento della sua “gloria” o “sopravvivenza” in ambito storico, necessita, richiede, esige d’essere tradotta. La traduzione è la risposta al bisogno dell’originale d’esistenza storica. La concezione, che esprime una visione della storia come ciò che dà senso alla vita e non viceversa, è radicale e innovativa (2). La sopravvivenza è la marca della capacità dell’originale d’avere una vita storica, richiamando a sé il “compito”della sua traducibilità.
In cosa consiste questo compito? Liberato il campo dal semiotismo e dalle scienze “borghesi” del tempo, capovolto catastroficamente il legame tra vita e storia, identificato il necessario rapporto tra originale e traduzione, Benjamin articola il senso della sua mossa teorica. La forma che il filosofo sceglie per la lingua della traduzione è un “abito regale” che avvolge il contenuto con le sue ampie pieghe, pur rimanendogli inadeguato e distante:
… la lingua della traduzione avvolge il suo contenuto come un mantello regale in ampie pieghe. Poiché essa significa una lingua superiore a quella che essa è, e resta quindi inadeguata rispetto al suo contenuto, possente ed estranea (p. 46).
………………………………
WALTER BENJAMIN, «Il compito del traduttore», cit. Vedi, qui, «Sulla lingua in generale e sulla lingua dell’uomo». Per una ripresa del pensiero benjaminiano in ambito critico, New Formations. A Journal of Culture/ Theory/ Politics ha dedicato un numero speciale a «Reading Benjamin’s Arcades», n. 54, Winter 2004/2005 (in particolare, vedi ESTHER LESLIE, «Stars, Phosphor and Chemical Colours: Extraterrestriality in The Archades»).
……………….
Cleopatra di William Shakespeare
- Il velo toccante

- «Ogni lettura è un viaggio; ogni viaggio è un invito ad
- abbandonarsi, all’abbandono – allo sconosciuto, con la
- grazia dei soffi e delle vele, lasciarsi andare».
- Mireille Calle-Gruber, «Imbarchi…»
- «…soffice si stenda
- Davanti ai tuoi piedi il tappeto del successo».
- William Shakespeare, Antonio e Cleopatra(1)

Il velo della traduzione tocca: il “velo toccante” è l’immagine di una trasformazione, per assonanza, del “tappeto volante” di una rêverie – Aladino, Le mille e una notte, l’esotico, l’immaginazione onirico-tecnologica, il trasporto, la leggerezza, la fede (il tappeto della preghiera, e quello che, nel mondo occidentale, si spiega per celebrare, in onore di…) e la differenza. Ancora, nella larga tessitura, il “velo toccante” è una metamorfosi, un esercizio di mappatura, un travelogue, il primo nomadismo della parola, seguito dalla metamorfosi che ha luogo tra due parole: il velo ed il tocco (2). Il velo, la materialità della fabbrica, ed insieme l’invisibilità di ciò che esso nasconde e protegge; il tocco, la qualità del più acuto dei sensi, il senso d’ogni sensibilità, la profonda questione del più superficiale dei sensi, se non la questione della superficie stessa: l’unità del tangibile. Un velo e un tocco – ciò che, in Occidente, ha marcato il pensiero sulla verità («La donna è la maggiore allegoria della verità nel discorso occidentale») e sul corpo («La femminilità è l’essenza o la verità della Donna») (3).Qui sarà possibile tracciare solo un’(im)possibile direzione del volo attraverso questo pensiero, trasportati dalla tessitura formale del velo toccante, come su un tappeto volante. Qualcuno, del resto, ha già annunciato che «stiamo lasciando l’occidente per perdervi l’oriente» (4).

- (1)WI LLI AM SHAKESPEARE, Antonio e Cleopatra, cit . ( Antony and Cleopatra, The Arden Edition, Methuen, London 1987).
- (2)Il tratto principale della tragedia è la “metamorfosi”: all’inizio, Cleopatra chiede «Che l’Egitto sprofondi nel Nilo e le creature/ Umane si trasformino tutte in serpenti!» (II, v, 78-79), quindi, chiude il cerchio, esprimendo il desiderio finale: «… trasformate, piuttosto,/ Nella mia forca le alte piramidi/ Del mio paese e impiccatemi lassù in catene» (V, ii, 60-62).
- (3)JACQUES DERRIDA, «Choreographies», in ELISABETH WEBER (a cura di), Jacques Derrida. Points… Interviews, 1974-1994, Stanford U.P., Stanford 1995, 96 (n. t.).
- (4) JACQUES DERRIDA, «Un baco da seta», cit., 24. Nella bibliografia decostruttiva, l’esperienza del viaggio è trascritta, in particolare, in JACQUES DERRIDA, Ritorno a Mosca, Guerini, Milano 1993; La contre-allée, La Quinzane Littéraire, Paris 1999; «Messaggio», in Viaggio in Palestina, Nottetempo, Roma 2003. Si veda, inoltre, il magnifico D’ailleurs Derrida di SAFAA FATHY, Arte Video, 2000.
……….
Cleopatra

“E’ in Oriente che sta il mio piacere” (II, iii, 43). Partizione, partitura, partenza: c’è bisogno di un accogliere e di un raccogliere esclusivi per far sì che l’Est si perda nell’Ovest. Nella tessitura dell’immaginario, sul palcoscenico mondiale, chi meglio può incarnare l’Est se non Cleopatra, la regina incantatrice d’Egitto,[1] la perla d’Oriente chiara come l’aria quando sorge il sole, il simulacro d’ogni esotismo e d’ogni orientalismo, la mistione connubiale tra alterità e femminilità, il centro di una misteriosa e nuova geografia?[2] Cleopatra è il velo che si stende dinanzi agli occhi dell’Occidente, seducendolo, intrigandolo, minacciandolo; allo stesso tempo, è ciò che tocca l’Occidente, esponendone lo sguardo ad un’apertura che è lo sguardo stesso, senza ritorno a sé se non per esporsi ad un senso diverso della sua storia. E’ il destino della figura – allo sguardo è offerta la sua nascita; lo sguardo è, però, incapace di afferrarne l’essenza. Cleopatra, l’attrice dell’incessante ‘divenire’ (la sua grazia o becomings, I, iii, 97), nasce sulla scena del teatro nell’azione originale di ‘stregare’ (la sua vocazione) Antonio.
- [1] L’Egitto potrebbe far da sfondo al compito ‘decostruttivo’ della regina. Cfr. J. Derrida, “Il pozzo e la piramide. Introduzione alla semiologia di Hegel” (1972), Margini della filosofia, Torino, Einaudi, 1997; Goeffrey Bennington, “Mosaic Fragment: if Derrida were an Egyptian …”, in Legislations: The Politics of Decostruction, London, Verso, 1994; Anidjar Gil, “Introduction ‘Once More, Once More’: Derrida, the Arab, the Jew”, in Gil Anidjar (a cura di), Acts of Religion, London, Routledge, 2001. Si veda, inoltre, Mario Perniola, Enigmi. Il momento egizio nella società e nell’arte, Genova, Costa & Nolan, 1990.
- [2] L’Oriente, che la tragedia inscena o evoca, reale e fantastico al tempo stesso (Asia, Eufrate, Siria, Lidia, Ionia, Media, Mesopotania, Cipro, Partia, Armenia, Cilicia, Fenicia, Libia, Cappadocia, Tracia, Arabia, Ponto, Giudea, Comagene, Licaonia…), è presentato, da un lato, come una ‘immensa pressione’ di corpi, e, dall’altro (è una non-contraddizione, se la (im)pressione è già incisione scritturale) come una scrittura che, nell’estraneità del territorio, viaggia nel corpo dello straniero “come paese. Questo straniamento, questa distanza che è il paese, in ogni paese e in ogni luogo: i paesi. Né territori, né domini, né suolo, ma quelle estensioni che si percorrono senza mai poterle riunire in una sinossi, senza poterle mai sussumere sotto un concetto. I paesi sempre stranieri – e lo straniero come paese, contrade, paraggi, passaggi, traversate, radure, rilievi inaspettati, sentieri che conducono in disparte, che si interrompono, partenze, ritorni: Corpus. Una scrittura che viaggia e vede, uno dopo l’altro, tutti i paesi del corpo”. Jean-Luc Nancy, Corpus, cit., p. 47.
- ——–





L’eredità di Cleopatra
L’aspide
Emily Dickinson
“Civilization – spurns – the Leopard!/ Was the Leopard – bold?/ Deserts – never rebuked her Satin –/ Ethiop – her Gold –/ Tawny – her Customs –/ She was Conscious –/ Spotted – her Dun Gown –/ This was the Leopard’s nature – Signor –/ Need – a keeper – frown?/ Pity – the Pard – that left her Asia –/ Memories – of Palm –/ Cannot be stifled – with Narcotic –/ Nor suppressed – with Balm –” (492).
——
Ribbon (34)
- «Le memorie della palma
- Non possono essere soffocate – coi narcotici
- Né soppresse – coi rimedi».
Domanda radicale, potenza della natura poetica, etica dell’incontro con l’alterità – l’ultimo appello della leopardessa di Emily Dickinson chiede che la memoria di tutto ciò non si soffochi o si sopprima, che non si usino narcotici o rimedi per negare il passato d’esilio dell’animale poetico. Sembra la richiesta che si testimoni alla posterità, ancora e sempre, l’intraducibilità della lingua (Palm, tradotto con “palma” o con “palmo”?), la varietà infinita delle lingue (l’estensione tattile della lingua di Cleopatra, la lingua poetica di Dickinson) e il loro esilio radicale (l’assonanza intraducibile tra Palm e Balm – palma e rimedio – in inglese, il gioco di un possibile misreading). Come tener fede all’appello? In verità, i dettati poetici possono essere “scritti”: nessun narcotico o rimedio, se non l’inchiostro per incidere nella memoria, portare altrove, tradurre. Serve un tessuto, una superficie, un materiale capace di inscrivere in sé le riflessioni sulla natura dell’interrogazione, ed insieme, quelle sull’avvenire del pensiero, un “velo” di traduzione:
… pensate alla parola nastro, ma anche a questa figura di una stretta banda di seta, velluto, o satin, che si porta sulla testa, sui capelli, o come una collana intorno al collo. L’origine incerta della parola nastro probabilmente lega i motivi dell’anello, così un legame circolare, l’anulare, o anche la banda matrimoniale, e band, nominalmente, ancora una volta il legame, come bind o Bund…
… questo pezzo di tessuto perso… era anche, una volta rubato e passato di mano a mano, una formidabile macchina da scrivere, un nastro d’inchiostro lungo il quale tanti segni transitavano così irresistibilmente, una pelle su cui o sotto la quale così tante parole saranno state stampate, un corpo fantasmatico attraverso cui onde d’inchiostro saranno state fatte fluire… Una biblioteca virtuale (35).
Il nastro della macchina da scrivere possiede capacità singolari: è circolare, un anello, una banda, un legame; allo stesso tempo, esso pratica la sostituzione – passa di mano a mano, ad indicare l’infinita virtualità delle incisioni che possono apportarsi sul suo tessuto. Grazie alla circolarità e alla sostituibilità, sul ribbon è possibile (ri)scrivere la “questione”, facendola circolare in una più ampia “interrogazione” sulla natura poetica, sostituendola quindi in una scrittura che pone l’impellenza della “richiesta” di affetto nei confronti dell’animale, nella differenza che il movimento della scrittura crea nel passaggio. Nelle infinite sostituzioni permesse dal nastro, appare così il frammento poetico che accoglie in sé la domanda filosofica “Ma io chi sono?”, traducendola sul piano dell’esistente: “Cos’è la vita?”. Il poema incompiuto «Il Trionfo della Vita» di Percy B. Shelley si scrive a partire da una serie infinita di domande, provocate dalla visione di una processione (il Trionfo) di spettri (36). Il ritmo interrogativo sembra avere la funzione di far avanzare il (Trionfo del) poema, ma, in realtà, mette in atto un processo più essenziale: l’interrogazione della natura retorica della lingua poetica, le sue figure, le sfigurazioni, gli esili linguistici. È la consapevolezza della natura retorica della lingua, allo stesso tempo, la straordinarietà della vocazione alla sua sopravvivenza, come affermazione trionfante della scrittura – sul nastro della macchina da scrivere, nel gioco delle sue sostituzioni, si iscrive adesso il romanzo contemporaneo più toccato dall’eredità romantica: Vergogna dello scrittore sudafricano J. M. Coetzee dedica la sua prima parte al “peso” del romanticismo in condizioni postcoloniali (37). Nello sviluppo della narrazione, l’eredità romantica è in realtà esposta alla “sublimità” di una lingua “femminile” ed, insieme, alla domanda radicale dell’“animale”; ne risulterà la scoperta di un nuovo senso d’accettazione dell’alterità, che depone il sapere e le sue prerogative, per portarsi alla consapevolezza, finale e dovuta, della necessità di una forma etica di rispetto per la sua vita, per la sua esistenza, per la sua morte.
«Il Trionfo della Vita» e Vergogna – cosa può tenere insieme due testi così distanti nel tempo? Sul nastro della macchina si incide una rilevanza storica: “Il Trionfo” è un testo non-epico e non-religioso; Vergogna viene dal Sudafrica post-religioso, postcristiano, post-storico, post-letterato (38). Sul nastro si scrive, allo stesso tempo, una vicinanza più intima: l’interrogazione tessuta dai due testi, la domanda sul significato del poema, di Shelley, del Romanticismo, ed, insieme, la domanda sulla sopravvivenza di tutto ciò in una scrittura post-coloniale che di esso si nutre, rappresentandolo ed incarnandolo nella struttura vera e propria della sua storia narrativa. È la “figura” che interessa, quindi il passaggio, la traduzione, all’animalità. Ancora una breve premessa: il nastro su cui si incidono questi passaggi o traduzioni, apparteneva inizialmente a Rousseau, per divenire poi il nodo di un contatto tra Jacques Derrida e Paul de Man; Rousseau appare ne «Il Trionfo della Vita» di Shelley come lo spettro che deve rispondere alle domande dell’io poetico; De Man e Derrida hanno entrambi scritto su «Il Trionfo della Vita», sulla soglia tra retoricità e sopravivenza; Coetzee ha scritto su Rousseau, citando De Man; il suo romanzo si scrive a partire dall’eredità romantica, esponendosi alla “lingua estesa” di un sublime femminile, ed accogliendo “la questione dell’animale” per poter percorrere la strada della traduzione culturale dall’apartheid alla post-colonialità (39). La macchina da scrivere, il computer, sono già in piena potenza…
- (34) Cfr. JACQUES DERRIDA, «Typewriter Ribbon: Limited Ink (2) («within such limits»)», cit. L’uso del corsivo qui utilizzato vorrebbe inscrivere sulla pagina «la transizione da un modo più assertivo, impersonale, teorico, a un modo di finzione e narrativo». JACQUES DERRIDA, Sopra-vivere, cit., 45 s.
- (35) JACQUES DERRIDA, «Typewriter Ribbon», cit., 323 (n. t.).
- (36) Pur nella diversità, entrambi lo spettro e l’animale sono legati da un’“alterità rimossa”.
- (37) J.M. COETZEE, Vergogna, Einaudi, Torino 2005 (Disgrace, Vintage, London 2000).
- (38) Alla lista va aggiunto il termine “post-coloniale”, nella consapevolezza precisa di una delle scene più inquietanti del romanzo: «al centro dello stanzone c’è uno degli invitati, un uomo di mezza età. Ha la testa pelata e il collo taurino: indossa un abito scuro e intorno al collo porta una catena d’oro con una medaglia grande quanto un pugno, di quelle che venivano conferite ai capitribù come insegna della loro carica. Emblemi sfornati a carrettate da una fonderia di Coventry o Birmingham: sul recto il profilo dell’acida Vittoria, regina et imperatrix: sul verso gnu o ibis rampanti: medaglie, capitribù, per gli usi consentiti. Venivano spedite in tutto il vecchio impero: a Nagpur, nelle Figi, sulla Costa d’Oro, in Kaffraria», ivi, 140. Per il carattere “postcoloniale” della scrittura di Coetzee, vedi DEREK ATTRIDGE, J. M. Coetzee and the Ethics of Reading, The University of Chicago Press, Chicago 2004.
- (39) L’interesse di J.M. Coetzee per la questione della “sopravvivenza” è testimoniato dal recente Spiagge straniere, Einaudi, Torino 2006 (in parti- colare, il saggio «Che cos’è un classico», ivi, 3-23). La scrittura di Coetzee interessata a Rousseau in riferimento a De Man, è «Confession and Double Thought: Tolstoy, Rousseau, Dostoevsky», Doubling the Point. Essays and Interviews, Harvard U.P., Cambridge, Mass. 2007.
- ……..
«Il Trionfo della Vita» (Percy B. Shelley)
…..
Ed è, sempre e solo, una questione di “veli” e di “tocchi«Il Trionfo della Vita» crea un sistema complesso di velamento e di svelamento, di tocchi di primavera e di metamorfosi che, nel rispecchiamento delle scene e delle interrogazioni (ciò che è offerto dell’esperienza del poeta si riflette in ciò che Rousseau, nel racconto della sua vita, dice d’aver esperito; ciò che chiede il Poeta a Rousseau ha la stessa forma di ciò che questi pone come domanda alla “Forma tutta luce”) mette in “estensione simbolica” la potenza della lingua.
E’, inizialmente. una questione di veli. Il poema incide sulla pagina l’iniziale sorgere del sole; sembrerebbe la forma naturale di un evento; in realtà: “veloce come uno spirito sollecito al suo compito/ di gloria e bene, il Sole all’improvviso/ sorse”. In inglese, ‘sorgere’ è ‘to spring forth’: il compito del sole è un movimento improvviso e rapido, senza contatto, imposto e di rottura, che fa cadere la maschera della notte dalla terra, aprendo (unclose) la scena all’orazione del mare, al canto degli uccelli, agli incensi del mattino (il testo mette in scena i contenitori – censers – ed, insieme, il contenuto – orient incence). In questo tempo, il Poeta si presenta, rimurginando pensieri che ‘devono rimanere non-detti’, mentre si posiziona all’interno del paesaggio: “di fronte a me la notte/ fuggiva; dietro di me il giorno sorgeva; il mare/ ai miei piedi, e il cielo sopra il mio capo”. Alla precisione della posizione poetica fa da controaltare l’effetto di una trance la cui ombra si stende, come un ‘velo di luce’, trasparente e chiaro (è il desiderio del Poeta?), a far baluginare (glimmer) le colline sottostanti. Il velo, nel baluginio della luce, apre la scena alla processione degli esseri non identificabili, insensienti, senza direzione se non quella del carro della Vita: “nessuno sembrava sapere/ dove stesse andando, o da dove venisse, o perché si trovasse tra questa folla” (47-48). Il giorno si oscura; una luce fredda copre il sole, come il sole fa con le stelle, mentre la nuova luna porta dentro sé lo spettro della madre morta e ripiegata su se stessa. Al centro del carro è una ‘Forma’, de-formata da un cappuccio impolverato e doppio, un alone scuro al posto del capo, col viso di Giano, il guardiano delle entrate e delle porte, degli inizi e delle fini, con quattro facce, e gli occhi bendati: gli elementi, le stagioni, i venti. E’ la guida delle forme che seguono, e del carro che le trascina, avanzando con velocità solenne. Nel procedere regale, la folla inscena una danza maniacale, un ironico ‘giubileo’ come quando Roma liberava gli schiavi per inneggiare ad un imperatore, ‘a triumphal pageant’ di uomini vecchi e miseri, sconfitti e aridi, invincibili ed emarginati, che, deposto ricchezze, troni e gemme, scompaiono ignorati e soli, oppure, torturati dalla ricerca del piacere, sono nel vortice, convulso e agonizzante, della mischia. Musica selvaggia, recessione di corpi che si piegano uno sull’altro, attratti e repulsi, esposti alla distruzione luminosa che ‘va e viene’; uomini e donne, dagli occhi grigi, scomposti, disordinati, dalle membra decomposte, ombre spettrali che interpongono tutt’intorno, tra loro ed il carro, il ‘velo di corruzione’ che li copre.
Dal ‘velo’ del mattino al ‘velo’ della corruzione – è ora il sorgere della ‘domanda’ poetica, l’investigazione della natura di ciò che il poema inscena. Mosso dalla vista, il Poeta non trattiene gli interrogativi: “‘Che cosa significa? Cos’è la figura dentro il carro? E perché?’” (177-178). Parla a se stesso; conscia dei suoi pensieri interroganti, una voce risponde: “‘La vita’” (180). Ciò che era sembrata una ‘radice distorta’, un manto di biancore che imperlava l’erba nel terreno pieno di buchi, è Rousseau, il capo canuto, gli occhi svuotati di luce. La sua apparizione segna l’istanza del dialogo tra il Poeta e la guida dantesca; è un dialogo che, in effetti, non ha luogo: le domande non ricevono risposta, ma incedono a creare nodi tematici e misteri che non vengono svelati, solo incisi più profondamente sulla pagina del poema, semplicemente esposti al desiderio di comprensione – compito difficile, quasi impossibile, già all’interno del poema; compito ancor più complesso per il lettore/la lettrice.
….
L’eredità di Cleopatra
Il limo
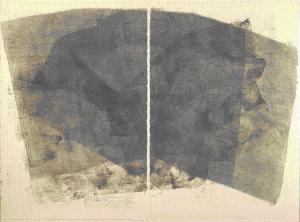
………
Fichu
- Voi ridete quando i bambini o le donne
- Vi raccontano i loro sogni?
- William Shakespeare, Antonio e Cleopatra
Il sogno di tutti: conoscere una lingua straniera (strana) e purtuttavia non comprenderla: cogliere in essa la differenza, senza che questa stessa differenza sia recuperata mai dalla superficiale socialità del linguaggio, comunicazione o volgarità; conoscere, riflesse positivamente in una lingua nuova, le impossibilità della nostra; apprendere la sistematicità di quello che non si può concepire; disfare il nostro ‘reale’ sotto l’effetto di altre suddivisioni, d’altre sintassi; scoprire posizioni sconosciute del soggetto dell’enunciazione, dislocare una sua topologia; in una parola, scendere nell’intraducibile, provarne la scossa, senza mai attutirla, sino a che in noi tutto l’occidente si scuota e vacillino le leggi della lingua paterna, quella lingua che ci proviene dai padri e che ci rende a nostra volta padri e proprietari di una cultura che appunto la storia trasforma in ‘natura’
(Roland Barthes, L’impero dei segni)
Materia, matrice, mater-ia; rifiuto dell’origine, valore della contro-firma, immaginario vulcanico: bruciando nelle sue follie e nei suoi paradossi, la questione della lingua materna costituirebbe l’indicibile puro, l’intrattabile per eccellenza. Pure, essa potrebbe tradursi in un ‘sogno’ – la lingua più familiare tradotta nella più estranea, la lingua onirica, la lingua del sogno.[1] In aiuto arriva un ‘velo’ sognante, il velo di un sogno, il sogno di un velo: il discorso d’accettazione del premio ‘Adorno’ da parte di Derrida, intitolato Fichus (il plurale di sciarpa, foulard), parola lasciata intradotta sulla pagina, a partire dal testo da cui è tratta: un sogno di Benjamin, trascritto e indirizzato a Gretel, moglie di Theodor Adorno. Il saggio di Derrida intreccia il pensiero di questo sogno con la considerazione del lavoro onirico da parte di Adorno, annotando, al contempo, le influenze lasciate dai due pensatori sulla sua decostruzione.
…….
L’Iguana
Così non meravigliarti, Lettore, se la malattia (così possiamo chiamare il pensiero) che da tempo minacciava il nostro conte, morto vivente nella sua classe, è esplosa nei modi tremendi che vedi, rivelando la sotterranea malinconia, la straziata esigenza del reale
Anna Maria Ortese, L’Iguana
La ‘contro-firma’ ibridazzante – ‘l’avanzante’ non chiude la storia, ma la riapre al suo possibile a-venire.[1] Tra origine e spettralità, istinto di morte ed archivio, letteratura e segreto, Napoli crede ai fantasmi, al ‘segreto’ che Anna Maria Ortese pensa come “le qualità di quelle persone che hanno dentro di sè qualcosa di ‘non umano’”.[2] Sono gli esseri che benedicono e perseguitano le case in Il Monacello di Napoli; sono le qualità non-umane della figura più misteriosa dell’universo ortesiano: L’Iguana. In questo straordinario testo, il sogno della lingua madre avanza, spostandosi nella circonferenza (murata) di un’isola al largo del Mediterraneo, nel deserto d’acqua e di pietra che accoglie in sé un enigma, legato ad una figura ibrida, posta a metà tra l’umano e l’animale, annunciata dalla ‘profezia’ che apre la rêverie: “Ci vorrebbero le confessioni di un qualche pazzo, magari innamorato di una iguana” (p. 17).[3]
……………….
- [1] In gioco è il ‘mistero’ di Gradiva: “Quali sono i ricordi d’infanzia di Gradiva?… Che cosa fa a Pompei? Passeggia con un passo che sembra simile al volo di un grande uccello… Ama il giovane archeologo?”, Hélène Cixous , Le troisieme corps, cit., p. 96. In particolare, in gioco è il ‘mistero della verticalità’ che il personaggio porta in scena: “la Gradiva: ecco gli esseri che sanno che l’avvenire non è un tempo che viene verso di noi che andiamo verso di lui su di un cammino orizzontale, ma che è questo presente dell’altezza di cui non conosceremo mai il limite, tempo alleviato, la cui principale qualità è la potenza (puissance). Questa potenza è assoluta, divina, pura di tutto il progetto umano, totalmente impiegata al solo progetto divino che è quello di svolgere la vita fino alle frontiere più estreme, al rischio corso cento volte di rincontrare la morte”, p. 46.
- [2] Per scusare il delirio di Herbert, Jensen fa dire a Gradiva che ‘ognuno ha una sorta d’insetto nella testa’. Dal canto suo, Anna Maria Ortese è stata spesso descritta come ‘una zingara assorta in un sogno’, a causa della sua biografia nomade (nata a Roma, si stabilì in Libia, poi a Napoli, Venezia, Milano e Genova), e per il carattere della sua scrittura, barocca e sensuale, posta nella linea ereditaria delle scrittrici mistiche: Angela di Foligno, Maria Celeste Crostarosa, Gemma Galgani. Cfr. Monica Farnetti, “Pavana per un’infanta”, in L’Infanta sepolta, Milano, Adelphi, 2000. L’associazione è motivata dalla scrittura poetica-profetica di Ortese, ispirata ad una ‘seconda vista’, ad una specie di ‘occhio obliquo’, che unisce l’immaginazione onirica e la visione estetica, la meraviglia e la rêverie. Questa scrittura in ‘transito’ ha prodotto Angelici dolori (1937), L’infanta sepolta (1950 – qui, una Madonna nera, con le mani simili a zampe d’uccello, è accompagnata da uomini alati, amici lunari, principi delicati, stranieri dolci e mortali –, Il mare non bagna Napoli (1953), Il porto di Toledo (1975). Vedi il bel “Oltre a resti di niente e sviscerato patire, l’impensato del reale” di Arturo Martone, in Aporie napoletane. Sei posizioni filosofiche, Napoli, Cronopio, 2006.
- [3] Cfr. Gérard Genette, “The Gender and Genre of Reverie”, Critical Inquiry, vol. 20, n.2, Winter 1994. Per Ortese, si potrebbe citare quanto dice Mireille Calle-Gruber, “Corpi”, cit., sulla capacità ‘profetica’ della lingua di Cixous: “Scegliendo lo sradicamento attraverso il gioco dei significanti e l’analogia poetica, che liberano le cose per gestire diversamente lo spazio della loro circolazione, Cixous procede al montaggio di spazi testuali nuovi. Apprende/ insegna ad abitare diversamente il libro e il mondo: cioè attendere, accogliere, ‘vedere’, profetare. L’invenzione del terzo corpo è questo stato di ricettività, un dispositivo. L’accoglienza. Un modo di leggere; lasciarsi leggere. Fare: posto”, p. 51. In L’Iguana, la ‘profezia’ è presto realizzata: dietro il tranquillo velo di nebbia che avvolge la città, deciso ad intraprendere il suo viaggio, il personaggio soggetto all’esperienza onirica del romanzo comincia a percepire, come in un sogno, “un segreto lamento di perduti”, p. 19.
- ….
L’idioma del gusto: Luna crescente di Diana Abu-Jaber
- Il mio potere
- E’ in fase crescente, e la speranza augurale
- Dice che arriverà al plenilunio
- William Shakespeare, Antonio e Cleopatra
‘E qui’, le tocca l’interno del gomito, ‘c’è la casa del coccodrillo del Nilo, con la sua bella voce quasi umana. E qui… c’è la pericolosa foresta che canta’.[1]
Cleopatra tocca la scena contemporanea con un’apparizione recente: Luna crescente di Diana Abu-Jaber, un romanzo intimamente toccato dal ‘gusto’ dell’idioma multiculturale,[2] narra di Sirine, una cuoca irachena-americana, dello stesso fascino della regina orientale: “un magnetismo delle cellule più profondo e intenso di ogni bellezza e seduzione” (p. 38); “il suo corpo reagisce a ogni cosa con la precisione di un diapason. Riesce a udire e percepire le cose più delicate, gli odori e la musica del suo pensiero”.[3] Sirine è una donna guerriera che sa tradurre la lingua della propria femminilità in momenti di eccezionale forza e potenza:
Donne che conquistano palazzi ed eserciti, spezzano incantesimi di silenzio e immobilità, mettono in scacco sfingi e demoni, conoscono i sette modi di sorridere e, alla fine, dopo aver risolto l’enigma, lasciano cadere la maschera, le vesti del marito, le armi e la penna, e tornano ad essere le donne di sempre (pp. 103-104).
Luna crescente narra il tempo della conquista, della vincita e della conoscenza di Sirine, nel momento in cui il velo della traduzione tocca il profondo della sua anima. Con la pelle bianca, dalla translucenza del colore del cielo, ed i capelli argento-biondo, è figlia unica di un padre iracheno e di una madre californiana, ‘relief workers’ morti nell’ultimo viaggio in Sudan, dopo aver vissuto, tra carestie, terremoti e guerre civili, in Turchia, in Africa, in India.[4] Il passato ha segnato la donna, che è amata da tutti ma che non ama nessuno; semplicemente lavora, con abilità eccelsa, in un ristorante che è luogo d’incontro di una miriade di esuli georgiani, siriani, libanesi, egiziani, iracheni, palestinesi. Ha trentanove anni, lo zio che l’ha allevata, due amiche libanesi, un aiutante messicano; intorno a lei ci sono il poeta arabo Haz Abdo, il giovane fotografo americano Nathan Green,[5] e Hanif Al Eyad, docente di studi mediorientali e famoso traduttore, un’Antonio iracheno esiliato da Bagdad a Los Angeles o, come dice il testo, a ‘Tegerangeles’, incapace di vivere perchè tormentato da una colpa segreta.[6]
- [1] Diana Abu-Jaber, Luna Crescente, Milano, Mondadori, 2003 (Crescent, New York, W. W. Norton & Company, 2003). L’opera è stata preceduta da Arabian Jazz, New York, W. W. Norton & Company, 1993, anticipando l’autobiografia o ‘food memoir’ The Language of Baklava, New York, Anchor Books, 2005. Fawa El Guindi, Veil: Modesty, Privacy and Resistance, New York, Berg, 1999, p. 10, ricorda che, in Occidente, la ‘luna crescente’, quale simbolo dell’Islam, è stata sostuita dal ‘velo’.
- [2] Calando la passione per la lingua nella singolarità dell’idioma – nel suo ‘gusto’, e non solo – sulle pagine di Luna Crescente si iscrivono i ‘corsivi’ che portano con sé l’(im)possibile compito della traduzione. Inizialmente, essi indicano i gesti del corpo: “Lo zio reclina la testa all’indietro, solleva le sopraciglia, fa schioccare la lingua. E’ un gesto che può voler dire tante cose: no, oppure, vedrai, oppure che sciocchezza, o anche non capisci proprio niente”, p. 14. In particolare, i corsivi riguardano la varietà dei cibi che tessono la materia narrativa del romanzo: la ‘cucina’ è mutbakh, e poi tabouleh, burritos, khoresht fessenjan, leben, knaffea, falafel, humus, pitta, labneh, mjeddrah, kharuf, kebab, baklavama, kabob, bulgur, tobbouleh, gh’rayba, shish kebab, lemon grass, foglie di limo kaffir, sfeehas, mensaf, mamool, mazza, fatayer, frekeh, baba ghanuj, frekeh, le frittelle qatayif ezakabyya, i biscotti ma’mul, il baba ganouj, il favoloso ‘id,‘id iftar, killaj, tagine, il liquore araq, la salsa tapini. Il corsivo cerca di comprendere il significato di ‘terrorista’ – fornendo le traduzioni gioventù e malinconia, p. 18 – ed, insieme, lo scherno e l’avvertimento di pericolo in ‘musulmano’, p. 39. Il corsivo esprime l’affetto: “min eedi – dalla mia mano”, p. 79, l’enfasi su una vita sotto dittatura, p. 100, ed, insieme, il pensiero silenzioso: “Com’è successo?”, p. 101, il timore per un destino di zitella, p. 116, il miracolo aucuba, e l’amore: “Ya elbi, ya hayati, mormora lui. Cosa vuol dire? Elbe significa ‘mio cuore’ hayati significa ‘vita mia’. Ya eyeni, occhi miei… Ya wardi, ‘fiore mio’, ya thahabi, ‘mio tesoro’. E’ una litania di parti del corpo, di elementi della terra e dell’aria, fisiche e metafisiche – mia rosa, mio settimo cielo, mio albero di fico, mio oro, miei sensi – come se fosse tutto legato dalla lingua speciale dell’amore”, p. 161. Il corsivo riporta la scrittura di due lettere (pp. 181-182; p. 362), sulle cui pagine appaiono le sirene ammaliatrici del mare: afrit o selkies, p. 213, ed, insieme, la benedizione Saltain ed il problema mishkila. Il corsivo iscrive il privilegio delle parole: “Faceva scorrere le dita sulle parole del vocabolario e poi scriveva sul quaderno le preferite: shelaal, asfoor, mismar, shemsiyya…”, p. 249, ed, anche gli eleganti caratteri fusha della lingua del Corano: “Per una settimana, forse anche due, Janet fece gli esercizi che Han le assegnava, sforzandosi di seguire con la matita le curve dell’ Aliegh, Baa, Taa… cercando di adattare le labbra ai suoni gutturali della lettera Eyn, dell’aspra Ghayn e della grave Dahd”, p. 257. Nell’incisione dei corsivi interviene la musica: la danza rituale sema, i suonatori dervisci mevlevi, il suonatore di oud, gli strumenti kanoon, rebab, il cantante di maqaam, una forma di canto tradizionale iracheno, p. 321, gli uomini ai dumbek, la musica rock’n’rai, e le liriche delle canzoni: “senna helwa ya jameela, un anno meraviglioso, oh Bellezza”, p. 365. Con i corsivi appaiono – in effetti, spariscono, al seguito di colui che parte – i marchi incisi sulle pagine di una vera e propria traduzione (di alcuni testi di Hemingway): “… le pagine delle traduzioni, scritte in arabo con la penna a sfera blu: Il grande fiume dai due cuori, Festa mobile e Il vecchio e il mare”, p. 345. Il corsivo rende i momenti della certezza affettiva: “Han lo sa”, p. 283, e dei ricordi: “Basta con le fotografie, ho visto anche troppo”, p. 377, “la cicatrice all’angolo dell’occhio le blocca il respiro. Han”, p. 379. In conclusione, i corsivi sanciscono l’orrore della guerra – “In Iraq muoiono ogni mese cinquemila bambini”, p. 388; “Han ha visto questo”, p. 390 – ed il pensiero della riconciliazione: “Pensa: Han è vivo”, p. 404.
- [3] I riferimenti alla tragedia shakespereana sono espliciti: “Dove è finita?” Protesta Um-Nadia. “Dov’è la nostra regina di Saba?… Hei, Regina! Dove ti sei ficcata?”, p. 90; “E’ un uomo così affascinante… Sarebbe il vostro capo. E Sirine la sua Cleopatra. Oppure la Regina di Saba”, p. 91; Sirine: “Io e Han ci siamo appena conosciuti. Non ho la minima idea di cosa potrà succedere. E’ un po’ presto per parlare di Antonio e Cleopatra”, p. 91; “Dov’è il nostro chef?… Cleopatra? Sei richiesta in cucina”, p. 122; “Ma sei tu, Cleopatra! Le afferra la mano e gliela bacia”, p. 171.
- [4] Abu-Jaber, nata da madre statunitense e padre giordano, come nota Marta Cariello, Corpi migranti tra le sponde delle lingue: Uno studio di tre autrici anglofone del mondo arabo, Roma, Aracne, 2006, “riflette criticamente sul processo di identificazione che informa la negoziazione delle politiche culturali contemporanee”. La questione è pensata da Jacques Derrida, Il monolinguismo, cit., p. 16, quando afferma che “Il silenzio di questo trattino non pacifica o calma niente, nessun tormento, nessuna tortura. Non farà mai tacere la loro memoria. Potrebbe addirittura aggravare il terrore, le lesioni e le ferite. Un trattino non basta mai a coprire le proteste, le grida di collera o di sofferenza, il rumore delle armi, degli aerei e delle bombe”. Per una ricognizione del dibattito sulle identità ibridizzate, prezioso è il saggio di Lidia Curti, “Letteratura della migrazione tra arte e testimonianza”, Voci Migranti DWF 3-4 (71-72) Luglio-Dicembre, 2006.
- [5] Nel ruolo che gioca in Luna Crescente, l’interesse fotografico rappresenta un retaggio della grande discussione post-coloniale sulla ‘fotografia’ avvenuta in Iran, come in J. Al-Ani, “Acting out”, in Veil, cit., pp. 90-106. In particolare, la fotografia, descritta all’interno del romanzo, è grafia visiva del ‘racconto dell’altro’ colto nei momenti di sofferenza e di estraniamento. Direbbe Roland Barthes, La camera chiara, Torino, Einaudi, 1980, p. 129: “Le due vie della Fotografia sono queste. Sta a me se decidere, se aggiogare il suo spettacolo al codice civilizzato delle illusioni perfette, oppure se affrontare in essa il risveglio dell’intrattabile realtà”. Vedi il bellissimo Retraits de l’ànima, Barcellona, Fundaciò “La Caixa”, 1997.
- [6] La narrazione delle vicende che fanno di Han uno studioso, è una scena di ‘traduzione’: il ragazzo dà lezioni di arabo ad una ricca americana; nasce tra i due una storia d’amore che fa sì che la donna, lasciando l’Iran, comunichi ai genitori di Han, grazie alla sua traduzione, l’intenzione di offrirgli una borsa di studio che gli permetterà di frequentare una scuola privata al Cairo (pp. 264-265.) Questa ‘traduzione’ provocherà, nel seguito delle vicende, il senso di ‘esilio’ di Han: “La realtà dell’esilio è più importante di ogni altra cosa nella mia vita. Lasciare il mio paese è stato… non so… come se una parte del mio corpo mi fosse stata strappata via. Ancora oggi provo dolore per un arto fantasma amputato da tempo. Sono tormentato dallo spettro di me stesso… L’esilio è come… E’ una stanza oscura, grigia e piena di suoni e di ombre, ma non contiene niente di reale. Per strada, ti sembra di incontrare vecchi amici, o vecchi nemici che ti fanno urlare ancora nei sogni. Ti avvicini, sicuro che siano membri della tua famiglia, e quando li vedi meglio ti accorgi che sono perfetti sconosciuti. A volte dimentichi di essere in America e non in Iraq. Tutto quello che sei stato, le immagini, i rumori, i sapori, i ricordi, tutto è cancellato. Dimentichi quello che credevi di conoscere”, p. 187.
….
La mobilità dell’arte: Abbas Kiarostami

- … ogni ‘arte’ è una totalità aperta sulle altre e configurata con esse, fino a toccarle
- Jean-Luc Nancy
- “Ho un’amica che è un’eccellente traduttrice. Non che abbia
- lavorato molto come interprete, ma se le si dà un testo in inglese o in francese è in grado di leggerlo subito e con estrema facilità in persiano, al punto di farvi pensare che stia effettivamente leggendo un testo già tradotto. Un giorno le ho detto: ‘se tu fossi mia figlia, non ti ammirerei per la tua capacità, ma perché non lavori mai’. Lei mi ha dato una risposta molto bella: ‘sono contenta di me stessa. Non ho voglia di veder comparire il mio nome sulla copertina di un libro come traduttrice’
- Abbas Kiarostami
Gli splendidi aiku di Abbas Kiarostami sono semplici, concreti, laici e terreni, pur capaci di stupire e di meravigliare.[1] Sono toccati al loro interno da una domanda che non risparmia nessuno, né l’io poetico né i lettori, il primo costantemente teso a riflettere su ciò che non comprende, gli altri esposti alla possibilità sempre aperta della credenza:
- Per quanto ci pensi
- non capisco
- la ragione di un tale biancore della neve (134)
- Mi sono ubriacato
- con una goccia di vino
- che ci crediate o no[2]
Nell’origine in-definita di un sapere incerto (Kiarostami parla di ‘inadeguatezza’ all’origine dell’opera artistica, ma anche di ‘tensione’ e di ‘attenzione’) e nel futuro di una testimonianza probabile (il necessario ‘compimento’ della creazione),[3] l’attenzione poetica si rivolge all‘unico soggetto d’amore possibile: “Perché il solo amore che aumenta ogni giorno d’intensità, mentre gli altri amori perdono la loro forza, è l’amore per la natura”.[4] I brevi componimenti poetici si lasciano toccare dall’intensità quotidiana del mondo animale, tessuto di galli, cavallette, cornacchie, api regine e operaie, colombe, oche selvatiche, cani, mucche, lucertole, mosche, libellule, vermi, rondini, serpenti, trote, lucciole, sciacalli, aquile, gufi, zanzare – “mille insetti”, “mille pipistrelli”, “mille pensieri”. Il mondo vegetale, a sua volta, si lascia riprendere poeticamente tra mele che cadono, gemme che sbocciano, rabarbari e trifogli, fiori senza nomi ed, insieme, girasoli, ciliegi, cachi, calle, belle di notte, crisantemi, gelsomini, fiori d’arancio. Ed, ancora, gli alberi, tanti alberi: platani, pini, quercie, salici, cipressi, olmi… I colori dei primi e la maestosità dei secondi si stagliano contro il cielo – “La luce, l’aria, il soffio… ambiente di passaggio, d’attraversamento e di rifrazione attraverso il quale l’immagine si realizza”[5] –, svaniscono nella nebbia, si coprono di neve, tracciano ombre, lasciano orme, si perdono tra le nuvole, s/compaiono e riappaiono. Nel loro farsi e disfarsi, essi tessono il luogo del contatto poetico:
- Un ragno/ ha iniziato il suo lavoro/ prima del levarsi del sole. (26)
- Un ragno/ interrompe il suo lavoro/ un attimo/ alla vista del levarsi del sole. (30)
- Un ragno/ unisce/questa volta/ i rami di un gelso e di un ciliegio. (74)
- Un ragno/ osserva appagato il frutto del proprio lavoro/ tra un gelso e un ciliegio. (80)
- Il sole fa brillare / le sue prime luci dorate/ sulla splendida trama di una tela di ragno. (81)
- Un ragno/ viene allontanato/ con garbo/dal velo di una vecchia monaca. (85)
- Il frutto di due giorni/del lavoro di un ragno/ viene disfatto/dalla scopa di una vecchia
- domestica. (113)
- Inizia / un ragno/ questa volta/ a tessere/ su una tenda di seta. (114)
- Il sindacato dei lavoratori/ alla fine/ non ha riconosciuto/ il lavoro del ragno.[6]
………….
- [1] L‘‘opera totale’ di Abbas Kiarostami vive nel contatto tra poesia, fotografia e cinema. La poesia appartiene già all’infanzia dell’artista: “Non sapevo ancora che si chiamasse poesia, ma faceva parte di me già dai tempi della scuola: ricordo che scrivevo, in forma d’appunti delle frasi qua e là”. Il tentativo giovanile di cimentarsi con la pittura si fa lascito di desiderio per la pratica fotografica: “Attraverso i colori cercavo di raggiungere la verità propria del naturale e quando dipingevo ero in uno stato di particolare relax. Adesso ritrovo lo stesso relax quando, con la macchina fotografica, passeggio in mezzo alla natura”. Segue, infine, il cinema: “Il mio contatto con il cinema è arrivato, invece, più tardi”. Abbas Kiarostami, “Al lavoro”, in Alberto Barbera – Elisa Resegotti (a cura di), Kiarostami, Electa, 2003, p. 125. A ciò va aggiunta la straordinaria esperienza teatrale di ‘Ta’ziyè’, presentata al Teatro India di Roma nel 2003.
- [2] Abbas Kiarostami, Con il vento. Poesie, Milano, Il castoro, 2001, costruisce una lunga sequenza sull’‘incomprensione’ del poeta: “Per quanto ci pensi/ non capisco/ la ragione di un tale/ ordine e splendore/ nel lavoro del ragno” (136); “Per quanto ci pensi / non capisco/ la ragione di un tale amore delle madri/ per i figli” (137); “Per quanto ci pensi/ non capisco/ la ragione di un tale attaccamento del cane” (138); “Per quanto ci pensi / non capisco/ la ragione dei calli sulle mani dei poveri” (139); “Per quanto ci pensi/ non capisco/ la ragione dell’amarezza nel vero” (140); “Per quanto ci pensi/ non capisco/ la ragione di una tale/ lontananza della Via Lattea” (141); “Per quanto ci pensi/ non capisco/ la ragione di una tale/ paura della morte” (142 (la numerazione in parentesi riporta le indicazioni del testo). Per l’appello al lettore, nella sua capacità più o meno possibile di ‘credere’, in Un lupo in agguato. Poesie, Torino, Einaudi, 2003 (il testo non presenta numerazione delle poesie, che indicherò con la pagina del testo), Kiarostami ripete: “Mi sono dissetato/ con una goccia di rugiada/ che ci crediate o no”, p. 187; “Ho fotografato un albero/ ed è arrossito/ che ci crediate o no”, p. 199: “A volte ho nostalgia/ di uno scappellotto/ che ci crediate o no”, p. 193.
- [3] Esprimendosi sull’intreccio tra poesia e cinema, Kiarostami nota che “Indubbiamente le poesie si creano per raggiungere un’unità nonostante la loro incompiutezza. Quando la mia immaginazione vi si mescola, la poesia diventa mia. Le poesie non raccontano mai storie. Offrono una serie di immagini: rappresentandole nella mia memoria, impadronendomi del loro codice, posso accedere al loro mistero. Raramente ho trovato qualcuno che di una poesia dicesse: ‘Non la capisco’… l’incomprensione fa parte dell’essenza della poesia. Si accetta così come è!”. Abbas Kiarostami, “Due o tre cose che so di me”, in Alberto Barbera – Elisa Resegotti (a cura di), op. cit., pp. 54-55. Il desiderio creativo sarebbe quello di riportare ‘l’incomprensione’ poetica al centro della visione cinematografica, per permettere al pubblico di completarne il senso, singolarmente e autonomamente.
- [4] Ibid., p. 58.
- [5] Jean-Luc Nancy, Abbas Kiarostami. L’evidenza del film, Roma, Donzelli, 2004, p. 33.
- [6] Abbas Kiarostami, Un lupo in agguato, cit., p. 98. Marco Vallora, “Guardare lo sguardo. Per una grammatica dell’immagine”, in Alberto Barbera – Elisa Resegotti (a cura di), op. cit., p. 86, si chiede se il componimento poetico “non sembri forse un fotogramma del suo cinema?… è importante che l’immagine rimanga così, parca di sè. Siamo sempre sulle soglie del deserto, anche espressivo, con Kiarostami… montaggi mentali dello spazio, accostamenti visivi di impossibilia figurali”.
……….
‘Dietro il velo’: il reportage di Saira Shah
- Andare. Verso l’altro che solo ha potere di leggere il mio segreto. Poiché il viaggio porta ad oriente, mi orienta verso il mio enigma intimo. M’intima
- Mireille Calle-Gruber, “Imbarchi…”
- Che la verità non è qualcosa che si possa stringere fra le dita, e che più ci si avvicina a un mito, più esso si ritrae?
- Saira Shah, L’albero delle storie
Esilio – contatto – intreccio: il percorso fin qui intrecciato vuole concludersi con una domanda sulla ‘rivelazione’ della possibile ‘verità’ nascosta ‘dietro il velo’ che ha sostenuto il pensiero della lingua pura, il contatto delle molteplici lingue, le sue traduzioni e le sue sopravvivenze, le (im)possibili promesse di futuro. ‘Dietro il velo’ è, in realtà, il titolo dello straordinario video che la giornalista afgana-inglese Saira Shah dedica alle violenze talebane sulla popolazione civile, una esperienza che si dimostra così toccante da provocare la scrittura L’albero delle storie. Il ritorno in Afganistan terra di leggenda e patria straziata, il reportage che indaga la verità dell’identità ibrida dell’autrice, la verifica delle storie che l’hanno prodotta e costituita.[1]
……………..
- [1]L’interesse per l’Afganistan è un rimosso che, come nota l’autrice, deve tornare al centro dell’attenzione mondiale: “Una volta l’Afghanistan era importante, ma poi sono successe così tante cose, li, e sono successe perchè l’Afganistan negli anni ‘80 veniva usato come pedina. Adesso non c’è alcuna attenzione all’Afghanistan a livello internazionale. Nel mondo, la gente deve fare attenzione all’Afganistan e può darsi che ne risulti qualcosa di buono”. www.cnn.com/ 2001/ COMMUNITY/08/24/shah/index.html.
[1] Jacques Derrida, Il sogno di Benjamin, Milano, Bompiani, 2003 (Fichus, Paris, Galilée, 2002). ‘Le Monde Diplomatique’ (supplemento a il manifesto), n. 1, anno ix, gennaio 2002, anticipò di un mese l’uscita del saggio in Francia, titolando la traduzione italiana “La lingua dello straniero”. Vedi Hélène Cixous, “Fichus et caleçons”, in Derrida. L’Herne, cit.
